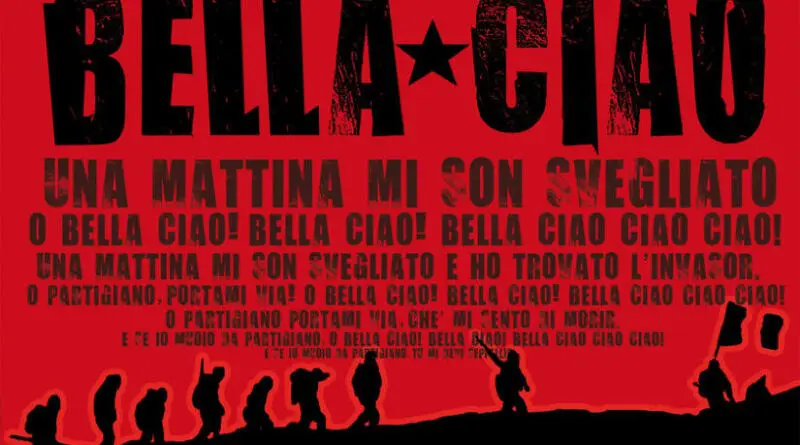L’Ucraina, la tragedia di Gaza. Oggi più che mai, assistiamo allo spettacolo quotidiano dell’interpretazione unilaterale di eventi di portata storica. Resoconti faziosi, al servizio delle opposte propagande.
Rappresentazioni di comodo? In Italia, il tipico specchio del fenomeno è l’annuale celebrazione, sempre più stanca, del 25 Aprile. È stata riproposta con surreale indifferenza anche nel drammatico biennio della “dittatura sanitaria”: si esaltavano le libertà riconquistate nel 1945, facendo finta di non vedere le libertà perdute nel 2020 e, l’anno seguente, vincolate al possesso del vessatorio “lasciapassare verde”.
Quest’anno, poi, in modo opportunistico, sulla festa della Liberazione il governo Meloni, mai completamente a suo agio con la memoria del Ventennio, ha calato il generosissimo sipario del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Cinque giorni di silenzio, in modo da mettere in sordina le glorie partigiane (appena richiamate provocatoriamente in Parlamento da Carlo d’Inghilterra, che sembrava quasi divertito nel mettere in imbarazzo un post-fascista come Ignazio La Russa).
Ma la “memoria fai da te”, manipolata pescando a piene mani dall’armadio multiuso della storia, inclusa quella resistenziale, non è prerogativa di una sola parte politica. Prima o poi, a quanto pare, qualunque potere (non importa di che colore) cede alla tentazione di maneggiare il passato a proprio uso e consumo.
Tanto per dire: il 18 ottobre 1997 l’allora presidente Oscar Luigi Scalfaro salì a Giaveno – in val Sangone, a trenta chilometri da Torino – per conferire alla cittadina alpina la medaglia d’argento al valor militare in virtù del valore delle formazioni partigiane della vallata e del sacrificio dalla popolazione, pronta a supportare i guerriglieri.
L’entusiasmo dei reduci durò poco: giusto il tempo di apprendere che, nei discorsi commemorativi al cospetto del Capo dello Stato, avrebbero dovuto tassativamente evitare ogni riferimento al fascismo. Incredibile ma vero: Scalfaro aveva “consigliato” agli ex combattenti antifascisti di richiamare solo il loro impegno contro l’occupante tedesco, come se i fascisti non fossero mai esistiti.
Motivo di tutto ciò? La preoccupazione del Quirinale per l’attivismo retorico del leader leghista Umberto Bossi, che in quel periodo agitava la minaccia secessionista. Dunque, non era pensabile rappresentare la storia in modo corretto e completo, cioè ricordando anche la sanguinosa guerra civile dei venti mesi partigiani: italiani contro italiani.
Gli anziani guerriglieri ancora vivi, presenti alla cerimonia, si sentivamo amaramente beffati. Il loro comandante, Giulio Nicoletta, sfidando Scalfaro ricorse a un giro di parole: insieme ai nazisti, accusò “gli ascari italiani, traditori della patria” che si erano messi al servizio dei macellai di Hitler.
La piccola val Sangone è meno nota di altre valli partigiane del Piemonte, ma in qualche modo seppe incarnare – come un vero e proprio incubatore – il carattere plurale della Resistenza, come premessa per la futura Italia repubblicana e democratica. Le tante brigate che agivano su quei monti seppero far coesistere le rispettive ispirazioni politiche. C’erano partigiani socialisti e cattolici, c’erano i comunisti (guidati da Eugenio Fassino, il padre di Piero) e c’erano persino i monarchici, agli ordini del marchese Felice Cordero di Pamparato (catturato dalle brigate nere e impiccato sulla piazza di Giaveno).
Sul fronte opposto, il podestà fascista Giuseppe Zanolli agevolava sottobanco la Resistenza procurando documenti falsi e passando informazioni riservate; fece persino evacuare un grosso borgo prima che venisse bombardato dai rastrellatori tedeschi.
Ad affrescare in modo esemplare quel microcosmo piemontese provvide Gianni Oliva, nel libro “La Resistenza alle porte di Torino”, edito da Franco Angeli nel 1989. Una memorabile testimonianza collettiva: in quelle pagine parlano i testimoni diretti della storia; non solo i protagonisti, ma anche e soprattutto le voci della popolazione costretta a subire le efferatezze del periodo.
Storico militare cresciuto all’ateneo torinese con docenti antifascisti come Guido Quazza, Oliva si è occupato della Seconda Guerra Mondiale, dei Savoia e delle tante pagine oscure del nostro passato recente, dal capitolo delle foibe al dramma degli esuli istriani di nazionalità italiana.
Oggi torna in libreria con un saggio (“45 milioni di antifascisti”, edito da Mondadori) che esplora “il voltafaccia di una nazione che non ha fatto i conti con il Ventennio”.
Memoria corta, insomma. Una sindrome dalla quale non sarebbe stato esente nemmeno il grande Dario Fo, insuperato mattatore teatrale e Premio Nobel per la Letteratura nel 1997. Negli anni ’70, il coppia con Franca Rame incarnò l’antifascismo più militante. Eppure, dice Oliva, c’era stata una rimozione: perché Fo aveva combattuto volontario nel Battaglione Azzurro, che raggruppava i paracadutisti della Repubblica Sociale.
Lo ricordò nel 1975 il “Giorno”, recensendo un bello spettacolo del Dario nazionale (il quale negò tutto e reagì querelando il giornale, che decise di ritrattare). Tre anni dopo, però, la questione tornò a galla. Su un piccolo periodico di Borgomanero (Novara), un lettore scrisse: si guardi bene dal venire a fare spettacoli da queste parti, Dario Fo, perché qualcuno potrebbe riconoscerlo come uno dei rastrellatori dell’autunno 1944.
Stavolta il processo si celebrò, il giornale (“La Tribuna”) esibì le foto del giovane Fo in divisa e l’artista fu costretto a cambiare versione: ammise di aver militato nel reparto fascista che aveva rastrellato la Valsesia, ma – aggiunse – si era arruolato d’intesa con due comandanti partigiani, per fare il doppio gioco e aiutare i ribelli.
Sfortunatamente, precisa Oliva, i due partigiani citati erano morti: non potevano confermare. Non solo: un ufficiale di collegamento italo-canadese, che aveva assistito i partigiani della zona, dichiarò di non aver mai saputo nulla dell’ipotetico infiltrato Dario Fo; se davvero avesse lavorato per la Resistenza, dopo il 25 aprile avrebbe avuto tutto l’interesse a rivendicare quel ruolo.
Dunque: se per il giudice non c’erano prove che Fo avesse partecipato al sanguinoso rastrellamento lungo il Sesia, di certo l’attore non fece una gran figura, politicamente parlando. Oliva ricorda il commento di Montanelli: se avesse ammesso tutto fin da subito, sottolineando che era ancora minorenne, la cosa sarebbe finita lì. Il problema, infatti – aggiunse Indro – non è ciò che si fa a 17 anni, ma quello che a 60 o 70 anni ci si ostina a negare di aver fatto da giovanissimi.
«In tanti, all’epoca, si erano trovati nella stessa situazione: per esempio l’attore Enrico Maria Salerno, il conduttore radiofonico Enrico Ameri (quello di “Tutto il calcio minuto per minuto”) e lo stesso Gorni Kramer, che dirigeva l’orchestra di Sanremo. Senza scordare Mauro De Mauro, il giornalista fatto sparire dalla mafia nel 1970».
Fra i 34.000 repubblichini catturati dagli americani – annota sempre Oliva – c’erano pure Walter Chiari e Raimondo Vianello. «Sornione com’era, Vianello fece un’intervista intitolata “Non rinnego nulla, né Sanremo né Salò”». La sua spiegazione: «Ero figlio di un ammiraglio della Regia Marina, ero cresciuto con quella educazione e quei riferimenti; avevo 17 anni, ho scelto la parte sbagliata ma non potevo sceglierne un’altra».
Walter Chiari invece non parlò mai di quel suo passato: era stato volontario nella X Mas. Però, ricorda sempre Oliva, «all’inizio dei suoi spettacoli diceva: “Saluto tutti quelli della prima fila e anche quelli della decima”, lasciando il dubbio se fosse la decima fila o la X Mas».
Tutte queste persone che cos’erano? Fascisti incalliti? No, risponde lo studioso: «Erano dei giovani, figli di quell’educazione, che avevano scelto la parte sbagliata della storia». Precisa lo storico: «Prima Violante e poi Ciampi definirono “ragazzi di Salò” quelli che nel 1943 andarono volontari nella Repubblica Sociale. Erano ancora giovanissimi, e tutti quegli anni di scuola avevano insegnato loro che l’onore e la bella morte, il morire in piedi, sono le caratteristiche a cui un uomo deve guardare».
Nel suo libro, Oliva formula un’accusa precisa: «Il fatto che, per tanto tempo, i cattivi, i veri fascisti, i duri, siano stati considerati solo quelli di Salò fa parte di quei conti con la storia che non sono mai stati fatti. Proprio questo ha permesso di assolvere tutti quelli che erano stati fascisti nel Ventennio, e che avevano accumulato onori, ricchezze, carriere e prestigio».
Non è mai indolore, la sincerità.
Lo stesso Togliatti, osserva ancora Oliva, prese con sé come consulente Gaetano Azzariti, ovvero il super-funzionario fascista che aveva redatto il testo delle leggi razziali. Lo scelse perché gli serviva un burocrate affidabile. Azzariti? Straordinario esempio di gattopardismo italico. «Di fronte a lui, gli ebrei si umiliavano inventandosi ascendenze non ebraiche nella speranza di essere risparmiati». Ebbene: sopravvissuto al crollo del regime, fu letteralmente miracolato dall’incarico ricevuto da Togliatti. «L’esser stato prescelto dal capo dei comunisti finì per riabilitarlo. E così, il giurista ultra-fascista e razzista restò in sella, nell’Italia democratica, e finì per diventare addirittura presidente della Corte Costituzionale».
Naturalmente, il caso Azzariti non è che la vetta dell’iceberg. «I diplomatici italiani, già fascisti, suggerirono a De Gasperi di non processare i nazisti responsabili delle peggiori stragi commesse in Italia, da Marzabotto a Sant’Anna di Stazzema, perché in quel modo poi la Jugoslavia, la Grecia e l’Albania avrebbero potuto fare altrettanto con i criminali di guerra italiani, che in questi paesi si erano resi responsabili di analoghi misfatti».
O ancora: «Va bene onorare la memoria dei valorosi 13 docenti universitari che rifiutarono di sottomettersi al fascismo; a patto però di non dimenticare i 1225 che invece accettarono di sottoporsi all’obbedienza. Per non parlare della corsa che si scatenò per prendere il posto dei 13 esclusi».
Le pagine di Gianni Oliva suonano scomode, specie tra le fanfare del 25 Aprile.
«Così come lo stesso Mussolini, al suo esordio, non potendo disporre che di squadristi, si adattò a reclutare burocrati dell’Italia liberale post-unitaria, allo stesso modo l’Italia antifascista dovette necessariamente accettare di tenersi il corpus di funzionari statali (ministeriali, giudiziari, accademici) che erano stati fascisti». A Togliatti, è vero, si rimproverò un eccesso di generosità, nell’amnistia. «Lui risposte: come potrei far condannare qualcuno per fascismo, se a processare gli imputati sarebbero gli attuali giudici italiani, rimasti tranquillamente fascisti per vent’anni?».
Fa male, fare i conti con il passato. Ma se si sfugge a quest’obbligo, chiosa lo storico torinese, si finisce per annegare nell’ipocrisia delle retoriche, svalutando persino il ricordo degli autentici combattenti. Se non altro, i partigiani testimoniarono l’esistenza di un’altra Italia. Ma il nostro paese, insiste Oliva, quella guerra la perse. E il fatto che questo non venga ricordato con nettezza non fa che indebolire il retroterra della nostra coscienza politica, che pare sconti un perenne deficit di onestà intellettuale.
(Il libro: Gianni Oliva, “45 milioni di antifascisti. Il voltafaccia di una nazione che non ha fatto i conti con il Ventennio”, Mondadori, 228 pagine, euro 19,50).